Da diversi anni sociologi e teologi parlano di “fine della civiltà parrocchiale”, indicando una crisi della presenza ecclesiale basata sulla parrocchia. Pensata nei secoli come luogo di nutrimento di chi già è credente e vive un forte legame di appartenenza locale, oggi la Parrocchia vive di linguaggi, appuntamenti, celebrazioni, ministeri non pensati per accompagnare una fede che molto spesso ha bisogno di ulteriore maturazione. L’esito? La difficoltà a intercettare una nuova domanda di spiritualità. In aggiunta, i sacerdoti si ritrovano a conciliare la vocazione con una gestione sempre più pesante.
È una riflessione che La Vita Cattolica sviluppa prendendo i passi dalla presentazione del volume “Rigenerare la parrocchia. Verso una conversione missionaria” a cura della Facoltà teologica del Triveneto, svoltasi lo scorso 5 dicembre on-line (Covi, Pierobon. Ed. Messaggero Padova). Ne abbiamo parlato con uno degli autori, don Rolando Covi; riportiamo qui l’intervista integrale, comparsa in un suo estratto sull’edizione del settimanale del 4 dicembre 2024.
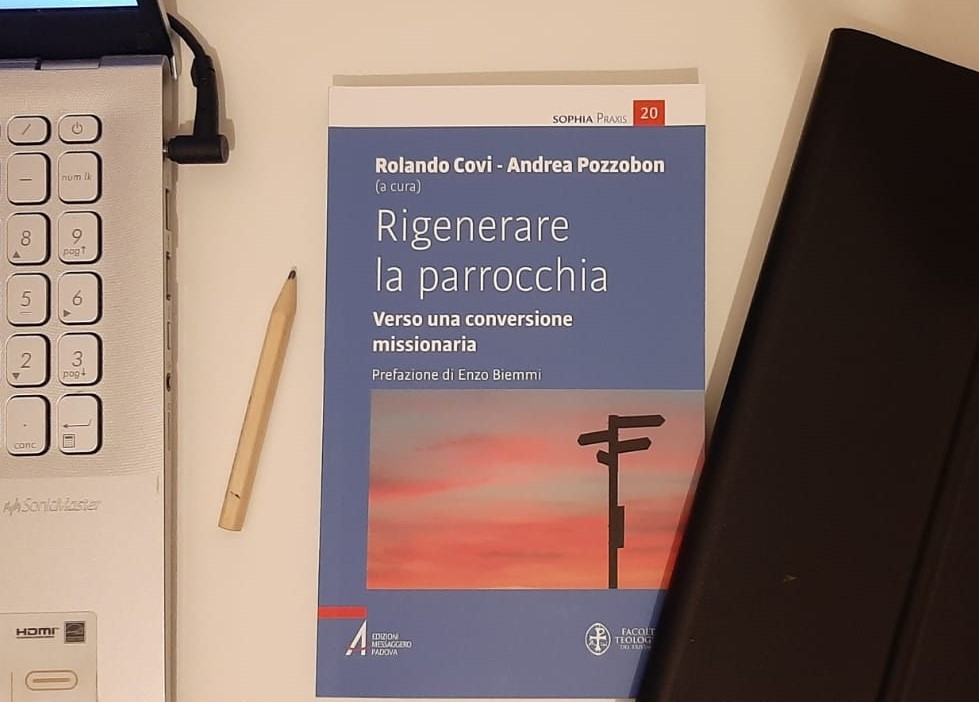
Don Rolando Covi, cosa si intende esattamente per Parrocchia?
«Il verbo greco paroikein, da cui il termine parrocchia ha due significati, tra loro complementari: vivere con altri, abitare accanto ad altri; essere pellegrino e forestiero, essere viandante. Il significato semantico identifica la realtà della parrocchia, che nasce e rinasce attorno a queste due polarità: una presenza di Chiesa in quel territorio, capace di assicurare visibilità e identità, ma allo stesso tempo una realtà mobile, leggera, nella forma della tenda, in continuo dialogo con la cultura in cui abita. La struttura giuridica si appoggia ed è chiamata a rimodellarsi a partire da questa identità, che si rinnova in relazione alla cultura in cui si colloca.»
Oggi alcuni parlano “fine della civiltà parrocchiale”, indicando una crisi della presenza ecclesiale basata sulla Parrocchia. Quali possono essere le cause di questa crisi?
«La parrocchia, pensata per assorbire ogni aspetto religioso della società, come esito di una evangelizzazione compiuta, ora si ritrova a dover rispondere a un appello missionario inaspettato. Come afferma la pedagogista Paola Bignardi, linguaggi, appuntamenti, celebrazioni, ministeri strutturati per gestire e accompagnare una fede generata altrove (principalmente in famiglia e nel contesto culturale), sono diventati insufficienti davanti a una domanda di spiritualità che non riescono ad intercettare. Così com’è strutturata, la parrocchia funziona bene dentro una logica di appartenenza e secondo una pastorale di trasmissione di un’eredità da far passare di generazione in generazione.»

È un appello a cui forse i preti in primis faticano a rispondere: sono sempre meno numerosi e hanno sempre più incarichi…
«I ministri ordinati vivono dentro uno spaesamento generale, visibile nella sua dimensione relazionale: il rapporto diretto con le persone è messo in crisi dalla struttura parrocchiale. Inseriti dentro un modello che pare aver terminato la sua efficacia, i preti sono chiamati addirittura a sostenerlo. In una frase, potrebbero dire: “Non è questa la Chiesa che sognavo”. La stanchezza non nasce dal troppo lavoro, ma dal sospetto di lavorare in modo inadeguato. In un articolo del 2007 don Giuseppe Laiti affermava che “è chiaro che la figura presbiterale si presenta oggi sofferente, insostenibile per il sovraccarico di incombenze e non nitida nella sua fisionomia, poiché non sono immediatamente leggibili le priorità effettive che la definiscono”. Si tratta di una sofferenza che chiede discernimento.»
Prima della Parrocchia va quindi ripensata la figura del parroco?
«La fine della “civiltà parrocchiale” ha costretto un ministro a spostarsi verso l’accompagnamento della crescita della fede. Dalla gestione di adulti che hanno già un’esperienza di fede, al servizio della fede di adulti in ricerca: lo spostamento non è piccolo. I cambiamenti culturali ed ecclesiali, così evidenti, pongono il prete da una parte dentro una miriade di occupazioni e dall’altra in una posizione sfasata rispetto alle priorità a cui lo richiamano i documenti magisteriali, come il primato all’evangelizzazione, il discernimento e la formazione della ministerialità. È il Vescovo Erio Castellucci, vicepresidente della CEI, a dire che se questa sfida non viene affrontata, si corre il pericolo di “perdere la gioia dell’annuncio”.»
Parliamo del rapporto tra la Parrocchia e il suo territorio, particolarmente debole in città. Ma dove la Parrocchia coincide con la comunità di un paese, magari lontano da altri centri, il legame è ancora significativo?
«La parrocchia non può perdere il legame con il territorio, perché è ciò che la rende realmente “cattolica”, cioè capace di parlare a tutti; tuttavia è chiamata a ritrovare un modo nuovo di abitare il territorio: da luogo semplicemente geografico delimitato a contesto dove riconoscere prima di tutto e poi accompagnare l’azione dello Spirito dentro i passaggi di vita degli adulti, quei nodi esistenziali dove la vita si apre all’accoglienza del Vangelo. Non è lo stesso vivere questo in una città, dove si possono pensare dei poli di collaborazione tra più parrocchie, valorizzando il carisma specifico di ciascuna comunità, o nei paesi più piccoli, dove la collaborazione diventa occasione di rinascere, per esempio nell’accompagnamento dei giovani o nella possibilità di organizzare una sagra parrocchiale come reale esperienza di fraternità. La domanda che accompagna il discernimento è quella sulla qualità relazionale: quali possibilità ha quella parrocchia di rendere visibile la gioia del Vangelo attraverso una rete di relazioni umane e umanizzanti? Questo vale per ogni parrocchia.»

Nel libro avete sostituito il termine “parrocchie missionarie”, con l’espressione “comunità generative”. Cosa cambia in termini di presenza ecclesiale sul territorio? E cosa, invece, in termini di proposte pastorali?
«La scelta nasce dalla volontà di non voler dar adito all’introduzione di un nuovo modello in grado di sostituire il precedente: si cadrebbe nella stessa fatica. Il termine “missionario” rischia da una parte di risultare in contrasto con la cultura contemporanea che, così segnata dalla libertà, finisce per interpretarlo come proselitismo; dall’altra invece potrebbe caricare le comunità, già affaticate, di una pretesa insostenibile. Parlare di generatività significa invece riconoscere i germogli di Vangelo che Dio sta facendo crescere: è una posizione umile, con lo sguardo di Dio, capace di rinnovare da dentro ciò che si sta già realizzando. Chiede il discernimento della vita pastorale con il Vangelo in mano, per ritrovare gli appelli dello Spirito dentro la realtà e così scegliere insieme che cosa lasciare e che cosa invece sostenere. È un’operazione che la Chiesa nei secoli ha già realizzato molte volte.»
Oggi molte Parrocchie hanno diverse strutture di difficile gestione (scuole, teatri, case in montagna, immobili). Tuttavia, una comunità cristiana ha bisogno di luoghi minimi per essere sé stessa: chiese, oratori, luoghi di carità, ecc. Anche qui si tratta di capire cosa sostenere e cosa lasciare?
«Mons. Erio Castellucci, nei suoi interventi durante il Cammino sinodale, ha parlato di una necessaria “cura dimagrante”. La parola “dismissione” ci fa paura, eppure è un’operazione inevitabile. Ma sappiamo come una cura dimagrante, senza criteri, rischia di fare del male. Per questo il discernimento di cui prima si parlava ha bisogno di un orizzonte preciso, che è quello della missione della Chiesa, intesa come il dialogo costante tra il Vangelo e la cultura in cui si trova, perché entrambi ne escano arricchiti.»

Se la sfida è quella di una nuova inculturazione della fede, di quali strutture abbiamo bisogno?
«Nell’ultimo secolo abbiamo lasciato strutture importanti, come scuole e ospedali, per aprirne di nuove, come altre forme di carità ci stanno raccontando. La Chiesa è chiamata a riconoscere le povertà che nessuno vede e a parlare di speranza lì dove nessuno ne parla, con modalità nuove; ciò che ha avviato da sola, può essere realizzato in collaborazione con la comunità civile, in una crescita reciproca, nel rispetto delle rispettive identità. Il riconoscimento dei fragili che nessuno ora riconosce è segno di Vangelo per tutti.»
Nell’Arcidiocesi di Udine abbiamo avviato da sei anni le Collaborazioni pastorali, reti fraterne di parrocchie. Nella vostra ricerca ed esperienza come valutate esperienze di questo tipo?
«È difficile valutare senza conoscere direttamente le realtà di una Diocesi. Mi pare che vadano tenuti in considerazioni alcuni fattori. Prima di tutto la motivazione: se si tratta di una semplice razionalizzazione, questa finisce per lasciare su pochi il peso di tanto lavoro; se invece il cuore di un ripensamento organizzativo risiede nel desiderio di rendere maggiormente visibile la gioia della fraternità, che diventa capace di fascino per altri, allora anche lo sviluppo dell’esperienza sarà diverso. Un secondo fattore è quello ministeriale: la singola parrocchia non ha più le forze per accompagnare la vita adulta, ma più parrocchie insieme possono esprimere momenti di formazione, di festa, di dialogo, di preghiera, di servizio con gli adulti che desiderano approfondire la fede. In tale direzione la Collaborazione pastorale può essere una valida proposta. Non va esclusa la possibilità di una incorporazione di alcuni enti parrocchia, nati nello scorso secolo, in un clima demografico e partecipativo totalmente diverso dal presente. Un ultimo dato: una comunità vive dove prega insieme a partire dal Vangelo; è questo il punto su cui non si investe mai abbastanza, al di là della forma di collaborazione.»
Va ripensato anche il rapporto tra preti e laici?
«Il ministero ordinato continua a rivelarsi l’unico modello per pensare anche altre forme di ministerialità, declinate soprattutto sulla dimensione sacerdotale, a scapito di quella di evangelizzazione e di guida. Nascono così ministeri di supplenza: solamente il presbitero ha il dono di gestire, controllare e dare vita a tutta l’attività pastorale; quando è impossibilitato a raggiungere un determinato luogo in un certo tempo, allora lo sostituisce un supplente. Oppure ministeri di delega: il ministero ordinato ha ancora tutta la responsabilità della missione, ma concede qualcosa di essa, dando possibilità di agire ai battezzati in un determinato ambito. Si tratta di tutti quei ministeri di fatto (catechisti, ministri della comunione, operatori Caritas, animatori d’oratorio, consigli pastorali) che nei saluti finali di un evento sono definiti “collaboratori del parroco”. Si fondano sul battesimo, ma sono soprattutto pensati per la conservazione della parrocchia in quanto tale: non si va a giudicare le singole persone, ma il sistema nel quale sono inserite.»

Entra in gioco la famosa corresponsabilità dei laici… ma si attua davvero?
«Solamente in alcuni casi si dà la corresponsabilità: la parrocchia è guidata insieme, per esempio in forma di équipe, e la partecipazione – la parola più delicata tra quelle che fondano il cammino sinodale – è vissuta nella sua effettività. Su questo ci sollecita di nuovo il vescovo Castellucci, quando già nel 2013 affermava che “Se il governo delle responsabilità parrocchiali potrà essere partecipato, allora uomini e donne potranno effettivamente partecipare alle decisioni. Tutte le sintesi sinodali lo chiedono”».
In un’epoca di legami sociali deboli e sfilacciati, in che modo la Parrocchia può essere un luogo in cui i legami si creano e si alimentano?
«Non sono sufficienti i momenti celebrativi, assembleari e funzionali perché ci sia una comunità cristiana: senza un’attenzione specifica alla propria vita, rischiano di essere luoghi “freddi”. La partenza per un cambiamento è possibile con quella parte di comunità formata da coloro che frequentano l’Eucaristia domenicale e da quanti sono impegnati in un ruolo più attivo: se queste due espressioni, pur numericamente ridotte rispetto alla comunità battesimale e a quella civile, escono dal sentore di una “massa indistinta”, tutta la parrocchia troverà un maggiore coraggio missionario, generato da una qualità fraterna più autentica. Il consiglio pastorale è posto a servizio di questo movimento.»
In definitiva, come dovrebbe cambiare la Parrocchia come la intendiamo oggi?
«Forse la risposta può sembrare banale, ma il cambiamento non avviene partendo dalle strutture, ma dalle persone. A prima vista, la forma comunitaria a dimensione familiare dei primi secoli, così come san Paolo racconta, parrebbe un luogo chiuso o di élite. I fatti parlano diversamente: le Domus Ecclesiae vivevano un’osmosi in due direzioni: dalla comunità esce la ricchezza della vita cristiana grazie all’annuncio dei suoi membri; nella comunità entra la ricchezza delle diverse esperienze culturali, sociali, etniche, antropologiche, che trovano un nuovo senso grazie all’incontro con il Vangelo. Da questa esperienza anche le attuali parrocchie possono trovare forza per rinascere, quando riconoscono e accompagnano nell’unità tra di loro i gruppi già presenti, a partire dalla condivisione della vita attorno al Vangelo.»
Giovanni Lesa












