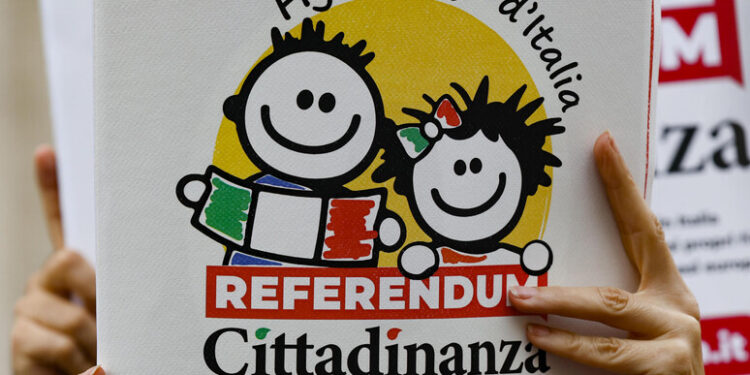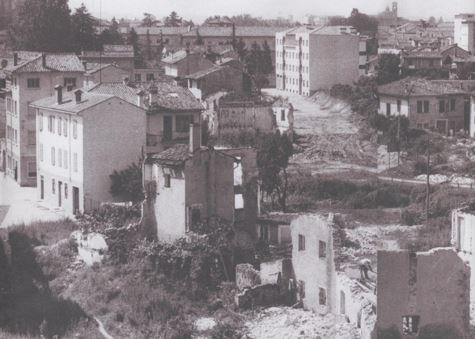La Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibile il quesito sul “Referendum di Cittadinanza”. Va ricordato, innanzitutto, che nella Costituzione Italiana il referendum è previsto dall’art. 75, quale strumento di democrazia diretta, attraverso il quale si permette ai cittadini di mantenere o eliminare una legge o una parte di essa, quando il legislatore non fornisce risposte esaurienti a problemi sentiti da una grande parte di cittadini, soprattutto a fronte di grandi mutamenti sociali.
Si tratta di superare una legge arretrata, come lo è la legge 91/1992 sull’ottenimento della cittadinanza italiana, così come richiesto dai promotori del referendum, sottoscritto dal 637 mila cittadini.
Il referendum abrogativo in questione è stato ritenuto legittimo dalla Consulta con la sentenza n. 11 del 7 febbraio scorso, considerandolo altresì omogeneo, chiaro e univoco. Esso si propone di dimezzare da 10 a 5 anni i tempi di residenza legale in Italia degli stranieri maggiorenni extra comunitari per ottenere la cittadinanza italiana, trasmettendone il diritto ai figli minorenni.
Rimangono invariati gli altri requisiti, quali la conoscenza della lingua italiana, un reddito adeguato, l’incensurabilità penale, l’ottemperanza degli obblighi tributari e l’assenza di cause ostative alla sicurezza della Repubblica.
Si andrà ai seggi, salvo che il Parlamento non modifichi nel frattempo la legge, nel periodo che va dal 15 aprile al 15 giugno 2025. Per la validità sarà necessario il superamento del quorum del 50% degli elettori.
Fin qui gli aspetti legislativi di questo referendum, sostenuto anche dall’associazionismo di ispirazione cristiana. L’Italia, come sostiene la Fondazione Migrantes, organo della Cei, è ormai un Paese delle cittadinanze plurime, con giovani italiani che vanno numerosi all’estero, mentre solo pochi fanno rientro e spesso sono privi della cittadinanza del posto in cui vivono e lavorano.
Allo stesso tempo numerosi lavoratori stranieri risiedono e lavorano in Italia, privi di cittadinanza italiana, ottenibile se non in tempi troppo lunghi.
Vi è, quindi, uno scollamento tra questa realtà e l’azione politica, che non sa interpretare il modo in cui la mobilità umana ha già di fatto mutato profondamente il concetto di cittadinanza. Si pensi, ad esempio, che da una recente indagine Istat emerge che tra i ragazzi non italiani dagli 11 ai 19 anni, oltre l’85% si sente italiano pur non essendo riconosciuto come tali, ancorché nato in Italia e desideroso di rispettare le leggi e le tradizioni italiane.
Non è quindi possibile che la politica non capisca che dal 1991 a oggi l’Italia è profondamente cambiata, divenendo Paese in cui la migrazione è ormai strutturale.
La Dottrina sociale della Chiesa evidenzia che nell’era della globalizzazione la cittadinanza non è soltanto una mera concessione dall’alto, ma piuttosto uno strumento di gestione del pluralismo e della diversità e quindi un’opportunità di inclusione, coesione sociale e condivisione.
Come evidenziato dai vertici della Conferenza Episcopale italiana, la Chiesa non può che farsi sostenitrice di una “visione larga” e inclusiva di cittadinanza. Non quindi non il frutto di “partigianeria politica”, ma solamente espressione di fedeltà a un Magistero che impone di mettere al centro di ogni ragionamento la dignità della persona umana.
Luigi Papais